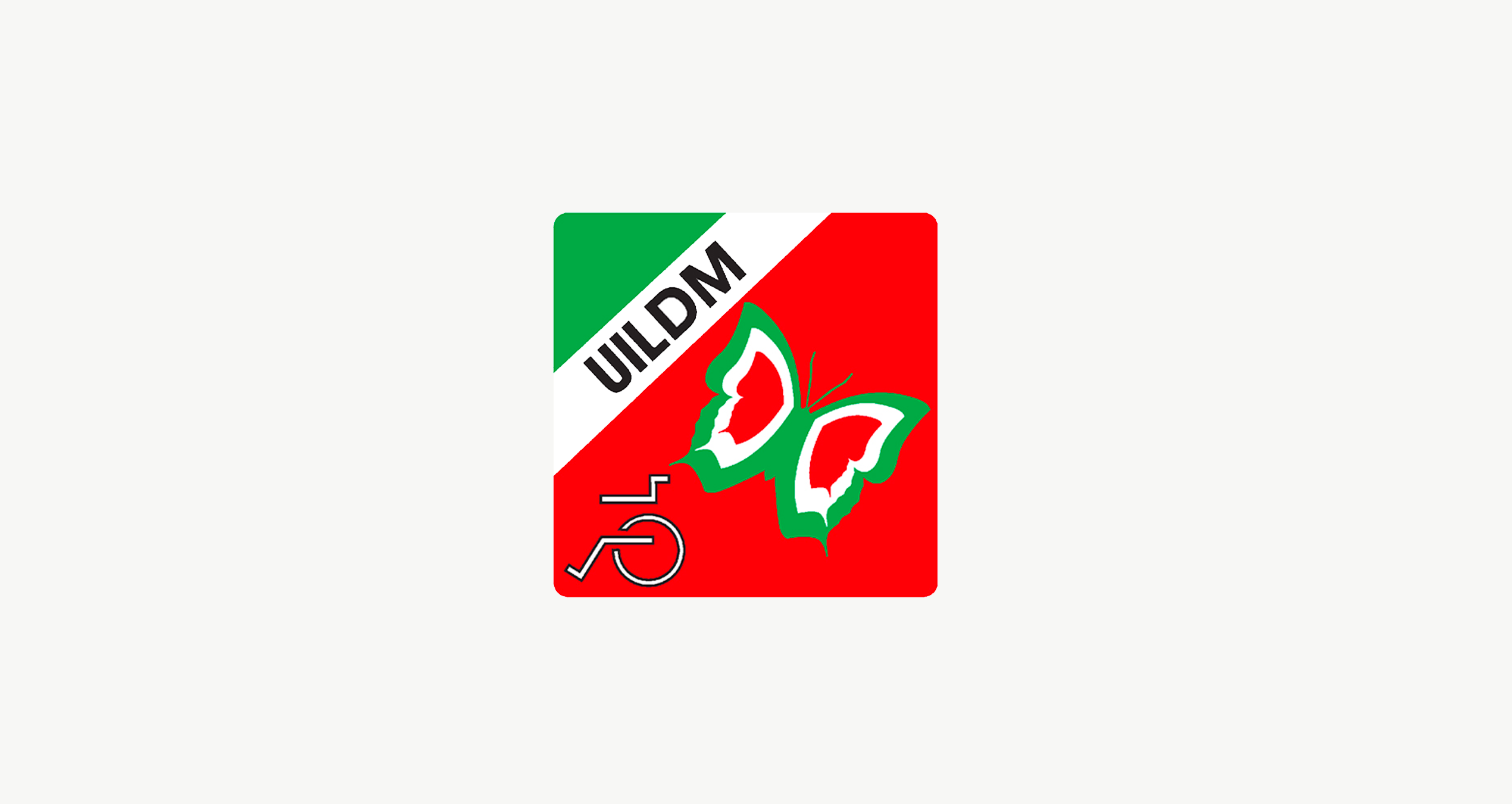Le diverse reazioni allo spettacolo di Antonietta Laterza e al filmato ci hanno indotto ad interrogarci sui modi più idonei per trattare il tema della sessualità e disabilità. Infatti di questo tema ci eravamo occupati anche altre volte senza che la cosa suscitasse risposte di chiusura e fastidio. Partendo da questa premessa, e considerando che non tutte le persone che seguono e collaborano col Gruppo donne UILDM hanno avuto modo di assistere allo spettacolo di Lignano, né di vedere il filmato di Antonietta Laterza, abbiamo pensato di coinvolgere anche queste persone traducendo la richiesta di riflessione in termini più ampi e generici. Pertanto abbiamo rivolto loro queste domande:
Quale è, a tuo parere, il modo corretto per parlare di sessualità e disabilità?
La sessualità delle persone disabili va trattata in modo diverso, specifico? Se sì, perché?
Pubblichiamo di seguito il parere di Marta Sousa, una psicologa interpallata sull’argomento, e le risposte delle altre persone che hanno aderito alla nostra iniziativa. Ovviamente ringraziamo sia l’una che le altre.
La partita della felicità
di Marta Sousa (psicologa)
In base alla mia esperienza non esiste un modo “corretto” per parlare di sessualità e disabilità. Possono coesistere differenti modi e diversi canali di comunicazione. Più è diversificata l’offerta comunicativa, maggiore è la possibilità che ogni persona trovi quella più affine alla propria sensibilità.
La sessualità delle persone con disabilità va trattata come sessualità umana. Partiamo dal presupposto che le persone disabili sono, appunto, persone, e che il loro percorso di sviluppo socio-affettivo-sessuale segue le tappe tipiche dell’essere umano. Posto questo, è ovvio che una riflessione specifica va fatta riguardo ai condizionamenti che la presenza di uno o più deficit motori, sensoriali o di altro tipo, può avere sull’espressione dell’affettività e della sessualità delle singole persone.
Un altro aspetto che merita attenzione è quello relativo ai condizionamenti socio-educativi. Infatti ognuno di noi cresce con dei modelli di riferimento collegati alla sessualità e con pratiche educative che condizionano l’espressione della stessa. Crescere in una famiglia che promuove l’autonomia e la socializzazione dei figli è, ad esempio, una circostanza che favorisce l’instaurazione di rapporti interpersonali e la capacità di creare legami affettivi con gli altri. Viceversa, crescere “nell’ovatta” spesso impedisce la costruzione di modalità relazionali sicure e gratificanti. La qual cosa, è evidente, ha ripercussioni anche nella sfera affettivo-sessuale. Questi aspetti però, lo sottolineo, non riguardano solo la persona con disabilità, ma tutte le persone. I pregiudizi e i condizionamenti sociali trovano un terreno più fertile nelle situazioni di chiusura relazionale e nella mancanza di confronto col mondo esterno alla famiglia.
Il terzo elemento che assume una rilevanza strategica è la personalità del singolo individuo. Infatti data una situazione fisica specifica, posto anche un certo percorso educativo, la persona potrà comunque scegliere come relazionarsi al proprio corpo e come impostare i rapporti interpersonali. E’ sulla possibilità di scelta ed autodeterminazione che si gioca la partita della felicità.
Altre risposte sul tema
Il diritto di desiderare: la legge è uguale per tutti!
di Monica Bruni
“E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”
Einstein
Qualche tempo fa, all’interno del Gruppo Calamaio, in cui lavoro in qualità di animatrice disabile, abbiamo riflettuto sul tema del desiderio e della sessualità vissuti dalle persone disabili. Un argomento, quello dell’intimità, per la maggioranza delle persone, siano esse normodotate o meno, che resta scottante e molto spesso difficile da affrontare senza false ipocrisie.
Di recente, proprio a questo proposito, ho letto un articolo su Superando.it in cui è stata stilata una lista, piuttosto provocatoria, curata da Valentina Boscolo, del Gruppo donne UILDM, sui pregiudizi nei confronti delle donne disabili da parte degli uomini normodotati. Cito alcuni interventi che ho ritenuto significativi:
La donna disabile è:
– L’amica perfetta degli uomini.
– Non è attraente e non è sexy.
– Non ha relazioni sessuali/sentimentali.
– Può avere relazioni sessuali/sentimentali solo con altri disabili.
– Una donna disabile si innamora facilmente.
– La donna con disabilità, è vista ancora più fragile, indifesa, vulnerabile rispetto alle altre donne,e persino rispetto agli altri disabili.
– Le donne disabili vogliono un amore per sempre…
– Le donne disabili non hanno desideri sessuali.
– Le donne disabili non conoscono la malizia.
– Le donne disabili non sanno ironizzare sulla loro condizione.
Da queste affermazioni emerge una figura della donna disabile fortemente stereotipata di cui, si può leggere chiaramente, le dirette interessate hanno piena consapevolezza. E’ impensabile, dal mio punto di vista, credere, per esempio, che una donna disabile si innamori facilmente, dando per scontato che non abbia né gusti né capacità di scelta autonoma o tanto più che un uomo possa essere considerato appetibile solo perché normodotato.
Anche chi è normodotato, d’altro canto non è necessariamente al centro dei pensieri di una donna solo ed esclusivamente perché le può dare supporto ed aiuto concreto nella quotidianità, idea, tra l’altro, purtroppo piuttosto diffusa da entrambe le parti. La visione della sessualità infatti per le donne con disabilità, secondo il mio punto di vista, non ha in sé nessuna fragilità anche se spesso ci si trova a fare i conti con la paura di provare sentimenti forti capaci di sfociare realmente in un legame vero e duraturo. Ciò non significa che le donne disabili debbano per forza volere “un amore per sempre”. La conoscenza dell’altro è un elemento, a mio parere, imprescindibile che richiede del tempo da investire nella scoperta fruttuosa di ciò che si può fare insieme, esplorando anche lati del carattere di entrambi, anche quelli un po’ più scomodi. Una relazione porta le persone a mettersi in gioco completamente e non è così scontato che il percorso termini con il traguardo di un rapporto stabile e felice. Due persone possono stringere dei legami anche meno impegnativi, ma comunque è bene percorrere la strada della disponibilità a condividere interessi e passioni solo se si è fatto su se stessi un lavoro di accettazione dei propri limiti e delle proprie capacità al fine di offrire un’immagine più grintosa e meno idealizzata della persona.
È fondamentale vivere le proprie esperienze sfruttando l’ironia, cosa che da sempre contraddistingue la mia vita come persona che si rende conto di avere esigenze diverse, che però, si integrano perfettamente in un mosaico di interessi che mi piace condividere con gli amici, per i quali, tuttavia, non sono mai apparsa come quell’amica perfetta così come emerge dalla prima affermazione.
Il pre-giudizio è un “giudizio anticipato” che ci porta a pensare alle cose a livello superficiale e crea delle immagini della realtà falsificate. Quello che non si conosce fa paura e, molto spesso, si preferisce evitarlo perché si vuole sfuggire alla situazione che crea turbamento. L’indifferenza ci porta a non mettere in discussione i nostri comportamenti che risultano standardizzati e non provocano nessuna trasformazione in noi e nell’ambiente.
Sono una persona alla quale piace molto il movimento e credo che la staticità si possa superare attraverso una messa in gioco di noi stessi in modo integrale, perché in fondo quello che ci muove è la voglia di oltrepassare le convenzioni arbitrarie a favore di una integrazione a trecentosessanta gradi .
Laura Bianchi
Più che parlarne il sesso bisognerebbe farlo, i disabili dovrebbero fare sesso, dovrebbero fare l’amore… dovrebbero poterlo fare… però bisognerebbe anche che ci fosse qualcuno disposto a fare sesso con noi disabili, disposto, pronto ad avere relazioni con noi… capace di prendere in considerazione come partner anche chi ha qualche problema, ed essere pronto ad amarci!
Maurizia Totis
Per me il modo corretto di parlare di questi temi consiste soprattutto nel parlarne senza tabù e pregiudizi.
Parlare di sessualità è anche parlare di sentimenti, emozioni, paure, dolore, felicità che uomini e donne provano, e questa universalità ci accomuna tutti, a qualsiasi latitudine. Credo che la diversità stia nel desiderio personale dell’espressione della sessualità. Naturalmente è bene conoscere i propri limiti specifici, ma solo per attuare nuove “strategie”.
Donata Gregoris
Sono Donata, la mamma di Benedetta, una ragazza affetta da SMA [amiotrofia muscolare spinale] di tipo 2, di diciotto anni. Nonostante la maggiore età, Benedetta sembra ancora tanto fragile e poco autonoma e responsabile. Ciò a mio giudizio, dal momento che lei la pensa diversamente. Io desidererei che Benedetta fosse prima di tutto FELICE e, per questo, mi piacerebbe molto che ricercasse, approfondisse e si confrontasse, ma si vede che non è ancora il momento o, forse, tiene tutto ben nascosto dentro di sé. Così rispondo io, per dire come la vedo, argomentando dal mio punto di vista. Magari successivamente, chi lo sa, scriverà anche lei.
Io penso che per vivere pienamente come PERSONE occorra conoscere, informarsi, relazionarsi, andare in profondità, fare esperienze e scambiarle, vivere il mondo dei DESIDERI e pensare che possano non rimanere tali. Se non si sogna e non si desidera NON SI VIVE. Ecco, questa è la mia idea di SESSUALITA’. Essa vale per tutti, indistintamente. A me piacerebbe che mia figlia la vivesse in questo modo.
C’è poi l’aspetto della genitalità che forse rappresenta una difficoltà maggiore nei casi di disabilità motoria. Per questo c’è bisogno di scambiare e confrontare pareri ed esperienze di vita vissuta.
La sezione UILDM di Udine, due anni fa, ha proposto un convegno che trattava proprio questi argomenti. Abbiamo utilizzato tutti i linguaggi utili per dare un messaggio a tutto tondo: esperienze di persone disabili, cinema, poesia, psicologia, scienza. E’ stato molto interessante ed efficace. Benedetta ha partecipato e le è piaciuto. Spero si possa ripetere e magari possa prendere parte anche lei all’iniziativa. Comunque credo che se ci fossero altre possibilità, ovviamente non tanto distanti, e con un coinvolgimento abbastanza diretto, parteciperebbe di nuovo.
Vorrei “pungolarla” di più ma NON POSSO!
Anna Pia Saccomandi
Per l’esperienza che ho di relazione con alcuni disabili, ritengo che loro siano molto più sinceri e disinibiti di molti cosiddetti normali nel trattare il tema senza tanti giri di parole. Quello della sessualità è un tema che interessa ogni uomo. Se nel caso delle persone disabili è stato ignorato per secoli, ciò è accaduto solo perché essendo loro più deboli, spesso sono state
trattate come bambini da proteggere. Con l’allungamento della vita, il miglioramento delle capacità relazionali, molti disabili hanno scoperto la possibilità di vivere pienamente la loro umanità.
Spero che la visione sessuale legata esclusivamente al concepimento sia stata superata definitivamente, e che si promuova invece una cultura del rispetto delle persone nella
ricchezza delle loro diversità.
Emanuela Pozzan
Donne e uomini sono accomunati da sempre dal vivere una vita simile, però sotto molti aspetti ci sono delle differenze. La sessualità è un tema molto personale e delicato, soprattutto perché può essere strumentalizzato e travisato.
Secondo la mia opinione di donna, la sessualità fa parte della vita come qualsiasi altro aspetto ed influenza l’atteggiamento e il destino. Le esperienze dirette e il luogo di crescita delle persone, influenzano molto questo aspetto della vita. L’ambiente dove veniamo allevati ci condiziona tanto. Alcuni nascono in famiglie aperte, ed altri in famiglie chiuse e all’antica. Sicuramente è importante anche la situazione fisica della persona.
La società è una, ma le persone sono tante, e spesso vengono “classificate” all’interno di gruppi. Esiste anche una “classificazione” relativa alla sessualità delle persone, che, a mio avviso, fa parte di un ordine superiore. Allo stesso modo in cui “classifichiamo” neri e bianchi, biondi e mori, maschi e femmine, normali e disabili, facendo riferimento all’orientamento sessuale distinguiamo tra etero e omosessuali, ecc.
Una classificazione si rende praticamente necessaria per il nostro ordine mentale, però questo bisogno di categorizzare ci rende vulnerabili alla discriminazione.
La differenza tra gli uni e gli altri deve servire come strumento e non come fonte di razzismo.
In ragione di questo atteggiamento alcuni sono portati a soffocare la propria sessualità, a non esibirla, a non esprimerla. Il tema comunque è molto delicato perché è suscettibile di volgarità. Tutto deve mantenersi entro limiti del buon gusto e del rispetto.
I disabili hanno una sessualità come qualsiasi altro essere vivente, e, pertanto, vanno trattati come tutte le altre persone. Non trovo giusto richiamare l’attenzione proprio sulla loro sessualità, perché fare ciò sarebbe come discriminare la categoria. Comprendo altresì che la sessualità per un disabile sia ostacolata dai limiti nella libertà di movimento, ma questo vale anche per altri aspetti della sua vita.
In conclusione, forse a causa della mie esperienza personale, ritengo che si parla troppo e spesso di sessualità dei disabili, ma approssimativamente e senza mai porre in atto delle cose pratiche, trattando sempre e solo l’argomento superficialmente e anche troppo ironicamente. Ritengo inoltre la sessualità una cosa intima, e parlare di questo mi sembra una violazione.
Liana Garini
Qual è Il modo corretto per parlare di sessualità e disabilità?
“So di essere differente, ma non mi sento male o in colpa per questo. Semplicemente sono come sono e non mi dà alcun problema. Voglio dire: chi è l’handicappato? Tu o io? Chi lo sa? Tu hai dei problemi, io ho dei problemi. Tutto qui.” Questo è quanto dichiarato a suo tempo da “Michel Petrucciani, uno tra i più grandi pianisti jazz. A causa di una malattia (osteogenesi imperfetta) era alto un metro e due centimetri” (Corriere della Sera, martedì 21 giugno 2011). Malattia che non gli ha impedito di avere varie storie d’amore, una moglie e un figlio.
“Sono timida e non riesco ad approcciare in modo diretto i ragazzi che mi interessano. Mi sfogo quindi con il porno e passo interi pomeriggi guardando filmati o foto di maschi superdotati”, così dichiara una 25enne che si confessa a Io Donna del 14 maggio 2011. L’occasione? Il servizio che indaga “… la porno-dipendenza: trappola subdola, nella quale sempre più donne rischiano di rimanere invischiate…”.
Due persone: una con una disabilità apparente, una senza disabilità apparenti. Entrambe con un desiderio di sessualità da soddisfare. Perché, quindi, usare un linguaggio diverso per parlare di sessualità?
Parliamone sì, di sessualità, ma parliamone tutti assieme, “normodotati” e “non”, senza distinzioni, come si fa per tanti altri argomenti di interesse generale. Magari con qualche distinguo, questo sì, per le difficoltà pratiche e tecniche che, per forza di cose, una persona disabile può incontrare nell’atto sessuale.
Altro discorso, invece, ovviamente, andrebbe fatto per una persona con disabilità psichica.
“La sessualità di una persona con disabilità fisica è una questione che va considerata in modo diverso da quella di una persona con una disabilità psichica? Logicamente sì. Se infatti l’accompagnamento sessuale per una persona in situazione di dipendenza fisica richiede nella sfera erotica qualcuno che agisca per lei, sopperendo anche alla sua mancanza di mobilità, per una persona con disabilità psichica c’è invece la necessità di imparare a entrare in contatto con il suo corpo, a ‘domarlo’, integrarlo, adattarlo e controllarlo. Due approcci, quindi, certamente molto diversi, ma anche complementari”. Da un’intervista a “… Marcell Nuss, francese, fondatore e presidente (a quell’epoca) del CHA (Coordination Handicap et Autonomie)…” pubblicata su DM, numero 162, giugno 2007.
Roberto Sudino
Mi presento, sono Roberto, ho una distrofia di Becker e sono gay. “Sessualità e disabilità” nel mio caso sono sempre andate a braccetto. Penso che il modo corretto per parlare di sessualità e disabilità sia innanzitutto parlarne per rompere il tabù! Una persona disabile può fare sesso ed avere una relazione sentimentale. Da persona omosessuale di mentalità aperta, alla domanda: “la sessualità delle persone disabili va trattata in modo diverso, specifico?” Rispondo: no, la sessualità non è normale, standard, di un tipo… è un universo complicato. Una persona, per considerarsi sana, dovrebbe curare anche l’aspetto della propria sessualità. L’argomento “sessualità-disabilità” è talmente affascinante, che spero venga discusso molto di più. Mi piacerebbe contribuire anche in maniera più impegnata sull’argomento.
Rosanna Nenna
Ciao, sono Rosanna, ho 40 anni, fin dall’età infantile sono affetta da atrofia muscolare, e sono vice-presidente della sezione UILDM sezione di Trani.
Ho ricevuto la vostra richiesta ed ho voluto anch’io esprimere la mia opinione riguardo al tema “sessualità e disabilità”.
Sono felicemente sposata da tre anni con Nino, ragazzo in ottime condizioni di salute, dopo un lungo fidanzamento durato 13 anni.
La sessualità è considerata un argomento ancora pieno di tabù per molti disabili che la affrontano con difficoltà, timidezza e cinismo.
L’intimità sessuale è vivere il piacere insieme, è avvicinarsi fiduciosi, è stare bene reciprocamente anche sessualmente.
Per alcuni, nella società moderna, la sessualità è indispensabile solo per far cercare due corpi “affamati”. Per altri la sessualità è un’intimità sensuale, una convivenza fisica e senza schemi mentali.
La sessualità nella disabilità è vista con tanti pregiudizi che, a mio parere, invece non esistono quando due persone condividono il rispetto e l’amore reciproco, corrisposto, e può essere ritenuta perfettamente normale, se considerata senza barriere culturali, sociali, morali e mentali.
Edoardo Facchinetti
Sono ben felice di poter riflettere su come e su cosa dire nel parlare di sessualità alle persone con disabilità.
Io personalmente parlerei il più normalmente e il più liberamente possibile, usando anche il linguaggio sessuato, di tutto ciò che riguarda la sessualità sia dal punto di vista esperienziale sia dal punto di vista psicologico, ”filosofico” e “morale”. Penso questo perché ogni persona, sia disabile che no, deve sentirsi completamente libera di fare domande e, viceversa, chi sta di fronte deve sentirsi completamente libero di poter rispondere se lo desidera e come lo desidera. Questa si chiama pari dignità.
Inizierei a far capire alle persone disabili che non possono e non devono usare la propria disabilità soprattutto se fisica come paravento, dietro il quale nascondere l’egoismo, la discriminazione anche eterosessuale, la volgarità e la banalizzazione di tutto ciò che riguarda il corpo e i sentimenti che con il corpo si esprimono. Al contrario nell’educazione e nell’autocoscienza vedrei bene tutto ciò che riguarda il concetto di autodeterminazione e di libertà.
Per quanto riguarda la mia esperienza, essa si può dividere in due fasi:
– La fase famigliare in cui non si è quasi mai parlato esplicitamente di sessualità, ma ho dedotto molto dalle cose fatte e da come sono state fatte soprattutto dalle figure femminili della mia famiglia e della rete parentale. Ho capito che si possono e si devono trattare le persone con un sovrappiù di tenerezza e di affetto e ho dedotto da tali esempi che ci si può autoeducare con Eros all’erotismo.
– La fase istituzionale, quei lunghi periodi passati in vari istituti, dove oltre a non poter parlare di sessualità ho dovuto introiettare un di più di paura legata alla mia omosessualità o bisessualità in ragione dell’ignoranza del personale. Non uso il temine ignoranza in senso offensivo, ma semplicemente per dire che il personale ignorava determinati meccanismi e messaggi, soprattutto non verbali, che ogni persona, sia disabile che no, sia volontariamente sia involontariamente, può mandare a coloro che le stanno intorno. Per questo ritengo essenziale una riflessione sui messaggi verbali e non verbali, e insisto sull’importanza che tali messaggi vengano fatti propri anche dal punto di vista emotivo ed emozionale.
Un altro aspetto che considero essenziale è il dover imparare ad avere un concetto di normalità il più ampio e il più inclusivo possibile. Un concetto che comprenda ogni forma di invecchiamento o di fragilità o di disabilità o del colore della pelle o di …
Ogni forma di “diversità” deve entrare il più possibile nel nostro concetto di normalità fino al paradosso di fare esplodere lo stesso concetto di normalità.
Quotidianamente entriamo in contatto, volontariamente o involontariamente, con storie di uomini e donne con diversi gradi di fragilità e di cronicità, con disabilità mentale o comunque grave, oppure con ritardo cognitivo. Queste storie e queste persone ci e mi pongono quesiti e tematiche estremamente delicati e complessi.
Ad esempio: come affrontare il loro desiderio di maternità o paternità, oppure le tematiche legate alla contraccezione, e, ancora, se, a nostro parere, anche loro, hanno diritto ad avere un’educazione all’Eros come qualunque altra persona, con o senza disabilità, carica di tenerezza e di concretezza. Con un’adeguata educazione anche costoro potrebbero realizzare forme di paternità e maternità non più singole, ma collettive, senza violare o abiurare la loro intimità, senza eludere la loro richiesta di intimità.
Se ci ponessero richieste di “assistenza sessuale”, ce la sentiremmo di dare loro dei suggerimenti?
Io sì, anzi, mi batterei affinché sul territorio di mia provenienza si potesse creare un gruppo di persone, composto di uomini e donne, che per loro sensibilità, o per loro strumento di autodeterminazione, accetterebbero di entrare in contatto con persone con varie forme di disabilità, e farei di tutto perché questo gruppo particolare venga riconosciuto dai servizi pubblici (come ogni forma di volontariato o di servizio), e perché i privati cittadini e le private cittadine possano finanziarlo attraverso il pagamento dei servizi svolti.
Anche se sintetico, spero di essere stato abbastanza chiaro, ma non banale o volgare.
Susanna Trippa
In riferimento al tema proposto, vorrei portare la mia voce di donna oramai in là negli anni – a ottobre ne compio 62 –, che ha avuto la fortuna di non avere grossi problemi fisici e mentali, e di avere avuto una vita sessuale ‘normale’.
Nella mia pseudo normalità, non so cosa posso capire realmente di chi vive, o ha vissuto, esperienze del tutto diverse.
Non ho ricette, né potrei averne.
La mia voce vuole solo esprimere la mia solidarietà a tutti per raggiungere quello che per loro è importante, in questo caso – se ho capito bene – qualcosa che per i ‘normali’ è dato per scontato e che invece per alcuni diventa quasi un tabù innominabile. Questo naturalmente vale anche per la bisessualità e l’omosessualità di persone che non hanno handicap fisici.
Ripeto che non ho ricette. Non sta a me trovare soluzioni. Però, penso che se ci fosse in tutti la consapevolezza che il diritto alla felicità (anche sessuale) è di ogni persona, allora si troverebbero anche le vie per arrivare al raggiungimento di questo obiettivo.
In termini più concreti, penso che dovremmo accettare il concetto di ‘diversità’ senza dargli un giudizio di valore. La ‘diversità’ esiste; se non la si guarda in faccia concretamente, se si finge che non ci sia, penso che non si possano neanche trovare soluzioni perché ognuno possa vivere meglio. Credo che si potrebbe guardare alla disabilità in modo diverso se cambiassimo angolazione di lettura.
Magari il mio vicino di vita ha un impedimento fisico che io non ho. Io però posso essere incapace e ‘cieco’ di fronte a cose importanti dell’esistenza. Posso cercare di ‘aiutare’ il mio vicino di vita disabile. Magari in questa occasione lui ha bisogno di me, ma io devo stare bene attento a non giudicare, a non pensare di essere ‘superiore’, o anche forse più fortunato (aggettivo che ho usato anch’io all’inizio), perché non si sa come stiano in verità le cose in questa vita che viviamo e che ci pare così reale…
Dunque la mia è solo una voce di accoglienza e di rispetto per le esigenze di ognuno, sempre che, a loro volta, non scavalchino i diritti di altri.
Elisa Di Lorenzo
Considerando il mio difficile approccio verso la tematica proposta – sia per la mia età (63 anni), ma anche a causa di quella ristretta educazione ricevuta negli anni cinquanta – sono un po’ dubbiosa sull’utilità del mio piccolo contributo, ma voglio ugualmente farvelo pervenire. Credo e spero comunque che qualcosa di utile io possa averlo appreso intorno a me durante la mia vita lunga e ricca di esperienze. Anche perché sono sempre stata molto attenta nell’osservare e nel riflettere a fondo sui comportamenti sociali e sulla velocissima evoluzione umana; specialmente quando le varie problematiche vanno ad incidere sulla qualità della vita quotidiana, e considerando che, negli ultimi anni, la disabilità ha toccato anche me.
Prima di tutto mi sento di dire che, secondo me, è molto importante approfondire il tema della “sessualità e disabilità” da voi già molte volte preso in considerazione e trattato con molta sensibilità e chiarezza, ma è anche vero che se già a livello della cosiddetta “normalità” risulta molto impegnativo parlarne, calarlo nel contesto dell’handicap credo lo sia ancora di più. Infatti, sebbene siamo nel 2011, persistono ancora oggi molte forme di discriminazione e pregiudizi che portano a tenere riservata, se non addirittura nascosta, questa esigenza.
Sono ancora moltissime le persone che, non essendo coinvolte da vicino in situazioni di handicap, discriminano le persone con limitazioni fisiche che, purtroppo, oltre alla personale sofferenza ingenerata dal convivere con il dolore causato da una malattia in continua progressione, si vedono anche costrette a spendere le già ridotte energie per difendersi da opinioni assurde, e spesso anche da leggi altrettanto assurde, per ottenere rispetto e vedersi riconosciuti i diritti civili.
Ritengo anche molto probabile che trattare questa delicata materia risulti ulteriormente complicato dalla circostanza che le limitazioni possono essere diversificate (vista, udito, vocali, motorie, menomazioni, ecc.), ma anche, e soprattutto, perché, a mio parere, vi una grande differenza, in termini di comprensione e tolleranza, tra il genere maschile e quello femminile.
Un altro elemento importante, che influisce in modo significativo sulla trattazione di questo tema, è l’età in cui si è costretti a confrontarsi con la disabilità. Infatti, se il tema è considerato serio e complesso in riferimento all’età adolescenziale, o comunque nella fase giovanile, esso riserva altrettanta grave e deludente tristezza anche quando la disabilità si manifesta in età ormai matura.
Per cui, se per la fascia giovanile diventa un’enorme carenza, per chi invece da sano si era già costruito un solido rapporto di coppia, si pone il problema – talvolta non risolto – di accettare la sopraggiunta diversità dell’altro. In questo modo rischiano di disgregarsi anche i rapporti più solidi, con un danno anche per i figli (che ne percepiscono la difficoltà e il disagio).
C’è quindi molto da dire intorno a questa delicata problematica, ed io, purtroppo, non ho competenze sufficienti a suggerire il modo più adatto per affrontarla. Tuttavia sono convintissima che voi, con la vostra squisita schiettezza giovanile, e con la vostra professionalità, ci riuscirete alla grande. Quindi, buon lavoro.
Io, con la mia buona dose di speranza e l’ottimismo che con il tempo ho imparato a conservare nel mio animo, posso solo dire che credo fermamente nell’AMORE e nel bisogno biologico della sessualità. Infatti quest’ultima è indispensabile per continuare a vivere i nostri giorni anche, e soprattutto, se colpiti da limitazioni fisiche.
Luca Mesini
Propongo la mia riflessione, ciononostante essa si basi su accezioni assolute, pertanto generiche.
Dal mio punto di vista, la disabilità è oggettiva. Gli equilibri all’interno e all’esterno della persona debbono reimpostarsi su un certo tipo di difficoltà per rimettersi ai loro criteri di fondamento percezionali: moto, azione, reazioni, bisogni espressi e bisogni che per esprimersi debbono comunque conversarsi con un “artificio” per svelarsi allo stesso modo per cui, invece, non si esprima il moto, l’azione e la reazione di una persona senza disabilità effettive (in particolare di deambulazione, coordinamento muscolare/vocale, cecità o sordità, e via dicendo).
L’aspettativa dell’equilibrio della vita sociale e dell’inter-relazione di una persona con disabilità è legata al grado di sviluppo e di espressione che si manifesta nel perimetro della sostanza della sua vita, quindi perfettamente riconducibile a quelle manifestazioni affettive, come quelle sessuali, che si possono evolvere al ritmo e in quella concezione dello spazio e della libertà di movimento o maturità espressiva percezionale acquisibile.
Ecco un esempio paradigmatico. Quando impariamo a disegnare, un utile esercizio è proprio dato dallo spazio: disegniamo una forma. Non solo un cerchio, un quadrato, un rettangolo, ma una forma strana, come una bolla di sapone con dentro altre bolle, o il perimetro di una nuvola, qualsiasi forma che inizia da un punto per poi muoversi, con curve, controcurve,
linee e zig-zag, fino a tornare a chiudersi nel punto da dov’è partita.
Ora: disegnamoci una persona dentro.
Dovremmo arrangiarci, no? La persona ha una testa, un collo, spalle, braccia, avambracci, gambe, polpacci, cosce, caviglie, degli addominali, dei pettorali, mani e dita. Non abbiamo altro modo se non metterla dentro quella forma muovendo come possibile la sua identità “oggettiva”, quei pezzi di sé, e tenendo conto della loro possibilità di mettersi o meno in una certa posizione.
Così è la sessualità nella disabilità, e, per analogia, ogni altra cosa su “tutto quanto accade e succede al merito dei protagonisti che possono per volontà fisica e dimensione fisica spaziale, fare accadere o far succedere”: il desiderio è un concetto e un diritto universale.
La fantasia e la creatività umana, direi la stessa umanità (che si premura di trovare, solitamente, soluzioni alle emozioni) è la forma che aiuta a trovare equilibrio fra sessualità e disabilità: noi prendiamo la forma nello spazio che abbiamo a disposizione per muoverci, per realizzarci e/o manifestarci. Tutto è conseguenza di un’azione, ma le azioni si plasmano sul territorio, sulle barriere o gli spazi accessibili che il territorio ci mette a disposizione. In parallelo, sugli strumenti che la nostra condizione di movimento espressivo ci permette di possedere, rendendo un gesto alla sua autonomia emotiva pratica ed effettiva.
Una persona con disabilità che avesse in dote grosse difficoltà espressive fisiche e motorie, sarà in ogni caso nel limite e nella potenzialità espressiva di quelle che sono le sue armi al merito.
Quale forte gesto empatico si renderà necessario per creare un argomento di intimità tale da poter permettere al soggetto di entrare in una dimensione “passionale” e sessuale con il diretto o la diretta interessata?
Un esempio reale. Molto tempo fa, una copia di giovani fidanzati iniziarono a lavorare nella loro piccola azienda familiare. Un giorno un grave incidente colpì il ragazzo. Le gravi ustioni su tutto il viso e gran parte del corpo compromisero la chimica stessa del corpo. Da quel giorno si rese necessario un anno di cure lenitive per ripristinare un sentimento di normalità. Questa nuova situazione mise i due ragazzi nella condizione di doversi confrontare con una diversa realtà, e con un concetto d’amore reale che fondava la loro unione di coppia anche, ovviamente, sulla sessualità. Quei ragazzi continuarono indefessi a lavorare per raccogliere quanto necessario alle cure mediche utili a ritornare alla dimensione iniziale. Quindi, uniti, si dedicarono allo forzo per riappropriarsi dei loro diritti, e del significato che i loro istinti chiedevano a loro stessi.
Come si evince, la sessualità, fin dove possibile, cerca di sormontare e smontare le barriere che incontra, e di liberare le persone. Ogni caso è un caso specifico, sono mille le variabili che incidono sulla verità di un accadimento espresso nel suo divenire. A volte credo che il desiderio sia come l’acqua che in migliaia di anni ha modellato la roccia, cercando e trovando di volta in volta la forma armonica per farsi strada.
Allo stesso modo due persone troveranno il modo di prendersi la loro libertà, loro sole. Perché sarà questa la ragione esistenziale che gli duole, e ogni dolore cerca infine uno sfinimento, un riposo, una soluzione, la quiete, il godimento del risultato o del fine raggiunto. Anche perché – come recita una canzone – non c’è sesso senza amore.
Edotto questo, la sessualità si manifesta in ogni situazione (anche in solitudine), non può certo subire forme di freno che non siano di pura natura possibilitaria (pratica e meccanica) fra persone diversamente abili e altre che apparentemente non hanno particolari difficoltà (per quanto ogni individuo possa averne una valanga, anche solo a livello di comportamento). Il tabù e la convenzione non inficiano la sessualità neanche in presenza di una disabilità, perché quando c’è amore fra due persone, questo tenderà a prendere forma, a cercare la forma per arrivare al suo desiderio, sempre e in ogni caso. L’Amore non ha barriere. La sessualità deve solo adeguarsi a quello che sente dal momento in cui la valutazione cognitiva o esperenzialmente emotiva si concede all’intuito per come la può vivere e descrivere, evidentemente nelle forme che si rendono possibili e percorribili.
Mi rendo conto che il discorso è teorico, ma in base all’enunciato del dibattito, forse ci sono degli spunti utili alla sostanza.