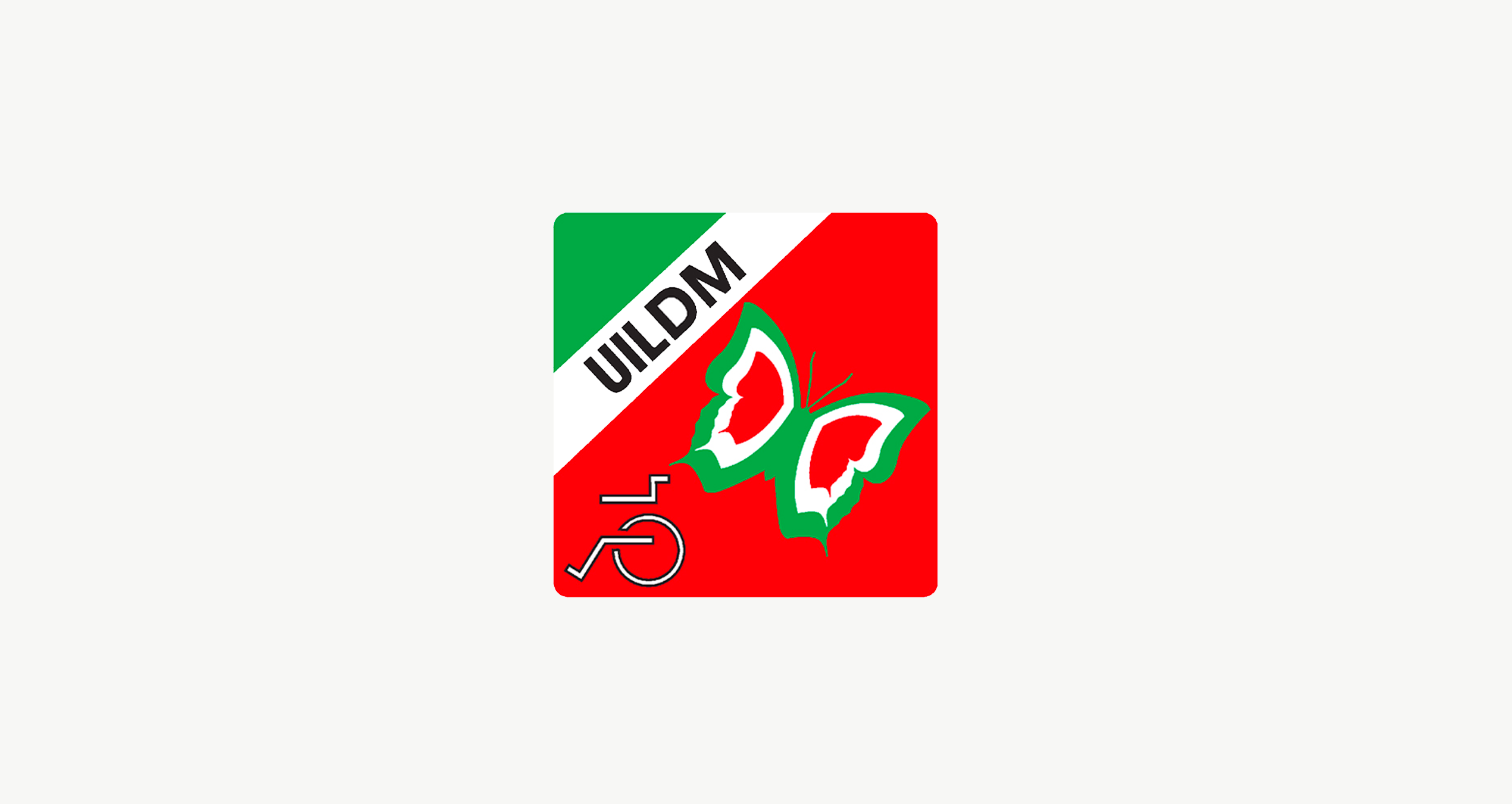In questa parte del nostro lavoro esponiamo i dati relativi alle caratteristiche personali delle persone intervistate. Consideriamo queste informazioni di estrema utilità ai fini di una corretta valutazione delle informazioni successive. In specifico abbiamo raccolto i dati relativi alle seguenti caratteristiche personali: età, stato civile, titolo di studio, condizione lavorativa, provincia di nascita, provincia di residenza e dimensioni dl comune di appartenenza (domande n. 1-7). E’ noto infatti che gli atteggiamenti e le opinioni delle persone variano in funzione di fattori personali (età, titolo di studio), sociali o relazionali (stato civile, condizione lavorativa) e ambientali e culturali (provincia di nascita e di residenza e dimensioni del comune di appartenenza).
Per rendere più chiara l’esposizione dei dati utilizzeremo delle tabelle di sintesi completate da una descrizione testuale delle stesse. Ci riserviamo inoltre di aggiungere tutte le considerazioni emerse in sede di elaborazione dei dati e che, a nostro parere, presentino una qualche utilità ai fini della nostra analisi.
Tabella n.1
Età delle persone intervistate
| Classi di età | Val. ass. | % |
| 15-25 | 4 | 5,9 |
| 26-35 | 18 | 26,5 |
| 36-45 | 19 | 27,9 |
| 46-60 | 19 | 27,9 |
| 61-70 | 6 | 8,8 |
| 71-80 | 2 | 3 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Dalla tabella n.1 emerge che l’82.3 % delle persone intervistate ha un’età compresa tra i 26 e i 60 anni. Si tratta quindi di un campione composto da adulti. Questo dato deve essere tenuto costantemente presente perché il fattore età è di primaria importanza nella trattazione di temi come l’affettività e la sessualità. Non si può infatti ritenere che un adolescente o una persona molto giovane abbiano riguardo a questi temi atteggiamenti identici o analoghi a quelli di persone adulte e presumibilmente più mature. Anzi è verosimile che tali differenze esistano e che siano significative.
Ciò che dobbiamo chiederci è come mai i più giovani sono così scarsamente rappresentati (5.9%). Si può pensare che loro abbiano maggiori difficoltà a parlare oppure che preferiscano affrontare questi temi con i loro coetanei o con persone delle quali hanno stima e fiducia.
Tabella n.2
Stato civile delle persone intervistate
| Modalità di risposta | Val. ass. | % |
| Nubile | 44 | 65 |
| Coniugata | 18 | 26 |
| Separata | 4 | 6 |
| Convivente | 1 | 1,5 |
| Vedova | 1 | 1,5 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Il 65 % del nostro campione è nubile. E’ una percentuale abbastanza elevata. Non si può escludere che la presenza della disabilità incida in una qualche misura nel determinare questo dato. Ad ogni modo si deve considerare che in Italia il numero dei matrimoni tende a diminuire, mentre tende ad aumentare il numero delle coppie di fatto (pur non essendo giuridicamente riconosciute). Nel valutare questi dati dobbiamo tenere presente che il questionario è stato formulato con domande aperte (senza risposte prefissate): questo significa che da esso potrebbero non risultare eventuali legami sentimentali socialmente meno formalizzati come, ad esempio, fidanzamenti senza convivenza.
Tabella n.3
Titolo di studio delle persone intervistate
| Titolo di studio | Val. ass. | % |
| Licenza elementare | 11 | 16 |
| Licenza media inferiore | 27 | 40 |
| Licenza media superiore | 23 | 34 |
| Laurea | 4 | 6 |
| Nessuna risposta | 3 | 4 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Per quel che concerne il carattere titolo di studio si possono fare le seguenti osservazioni: il 16 % di persone con la sola licenza elementare è un dato che va valutato in relazione all’età non giovanissima delle persone intervistate; il fattore età deve essere considerato anche nella valutazione degli altri dati. La prevalenza di persone con licenza media inferiore (40%) può essere letta sia considerando che in passato le persone disabili avevano, rispetto ad oggi, meno opportunità di proseguire gli studi; sia prendendo in considerazione l’ipotesi che la disabilità costituisca per molti un impedimento alla carriera scolastica. In ogni caso non deve passare inosservato che il 40 % del campione possiede un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.
Tabella n.4
Condizione lavorativa delle persone intervistate
| Modalità di risposta | Val. ass. | % |
| Disoccupata | 19 | 28 |
| Impiegata | 18 | 26 |
| Pensionata | 14 | 20,5 |
| Casalinga | 7 | 10 |
| Studente | 3 | 4,5 |
| Volontaria | 3 | 4,5 |
| Nessuna risposta | 3 | 4,5 |
| Terapista | 1 | 2 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Il problema della disoccupazione è molto forte in Italia e quando esso si combina con la disabilità i risultati sono quelli che emergono dalla tabella n.4. Da questa tabella emerge che solo 28 % delle persone intervistate svolge un’attività retribuita. Ciò deve far riflettere. Che oltre alla disabilità incidano anche fattori legati al genere di appartenenza?
Desta inoltre curiosità il fatto che tre persone pensino al volontariato come ad un lavoro.
Per rendere più snella, e dunque più comprensibile, l’esposizione, nella tabella n.5 (pagina successiva) abbiamo suddiviso le provincie di nascita per regione. Mettiamo in evidenza che questi dati si riferiscono al luogo di nascita delle persone intervistate e non alla residenza attuale (di cui tratteremo nelle tabelle: n.6a,a pag.14; n.6b, a pag.15 e n.7, a pag.16).
Tabella n.5
Area territoriale di nascita delle persone intervistate
| Area territ | Val. ass. | % |
| Veneto | 23 | 34 |
| Lombardia | 13 | 19 |
| Friuli Venezia Giulia | 9 | 13 |
| Puglia | 4 | 6 |
| Sicilia | 4 | 6 |
| Emilia Romagna | 3 | 4 |
| Liguria | 2 | 3 |
| Toscana | 2 | 3 |
| Campania | 2 | 3 |
| Sardegna | 2 | 3 |
| Piemonte | 1 | 1,5 |
| Marche | 1 | 1,5 |
| Svizzera | 1 | 1,5 |
| Nessuna risposta | 1 | 1,5 |
| Totale | 68 | 100 |
oriale
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Se proviamo a raffrontare la tabella n.5 con quella successiva (contenete i dati relativi alla residenza) scopriremo che i dati in esse contenuti sono quasi sovrapponibili. Ciò significa che le persone intervistate tendono a rimanere nei luoghi di origine.
Tabella n.6a
Area territoriale di residenza delle persone intervistate
| Area territoriale | Val. ass. | % |
| Veneto | 23 | 33,5 |
| Lombardia | 12 | 17,5 |
| Friuli Venezia Giulia | 12 | 17,5 |
| Puglia | 4 | 6 |
| Liguria | 3 | 4,5 |
| Emilia Romagna | 3 | 4,5 |
| Sicilia | 3 | 4,5 |
| Toscana | 2 | 3 |
| Sardegna | 2 | 3 |
| Piemonte | 1 | 1,5 |
| Marche | 1 | 1,5 |
| Nessuna risposta | 2 | 3 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Adottando lo stesso criterio utilizzato per i dati sulle provincie di nascita anche per le provincie di residenza abbiamo scelto una suddivisione per regione (tabella n.6a). Specificando ulteriormente i dati in essa rappresentati il Veneto ha partecipato con le seguenti provincie: Verona (9 questionari), Padova (8 q.) e Venezia (6 q). La Lombardia: Bergamo (5 q.), Mantova (4 q.), Brescia (2 q.) e Pavia (1 q.). Il Friuli Venezia Giulia: Udine (7 q.) e Trieste (5 q.). La Puglia: Brindisi (2 q.), Bari (1 q.) e Lecce (1 q.). La Liguria: Genova (2 q.) e Savona (1 q.). L’Emilia Romagna: Modena (3 q.). La Sicilia: Palermo (3 q.). La Toscana: Livorno (1 q.) e Pistoia (1 q.). La Sardegna: Sassari (2 q.). Il Piemonte: Asti (1 q.). Le Marche: Pesaro (1q.).
Come si può notare, nella tabella n.6a si configura una distribuzione alquanto eterogenea in cui la partecipazione delle regioni del nord risulta enormemente più consistente di quella del sud. Dato che vogliamo rendere ancora più esplicito nella tabella (n.6b) che vi proponiamo nella pagina successiva e in cui abbiamo raggruppato le regioni ricorrendo alla quadripartizione di uso comune tra nord, centro, sud e isole. Il risultato è estremamente significativo.
Tabella n.6b
Area territoriale di residenza delle persone intervistate
| Erea territoriale | Val. ass. | % |
| Nord | 54 | 79,5 |
| Isole | 5 | 7 |
| Sud | 4 | 6 |
| Centro | 3 | 4,5 |
| Nessuna risposta | 2 | 3 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
Forse nelle isole, al sud e al centro gli argomenti trattati dal questionario risultano maggiormente problematici per le persone a cui è stato sottoposto. L’incidenza dei fattori ambientali e culturali ci sembra la più verosimile. Tuttavia non possiamo escludere che anche altri fattori possano aver contribuito determinare questi risultati. Possiamo ipotizzare una difficoltà delle Sezioni UILDM nella distribuzione del questionario postale; una diffidenza nei confronti di questo strumento di raccolta dati da parte delle persone a cui era rivolto o, ancora, un debole interesse di queste persone verso l’attività dell’Associazione.
Tabella n.7
Dimensioni del comune delle persone intervistate
| Modalità di risposta | Val. ass. | % |
| Medio | 31 | 45,5 |
| Grande | 23 | 34 |
| Piccolo | 13 | 19 |
| Nessuna risposta | 1 | 1,5 |
| Totale | 68 | 100 |
Fonte: nostra elaborazione su dati raccolti con questionario postale.
I dati relativi alle dimensioni del comune di appartenenza hanno probabilmente, rispetto agli altri finora trattati, un rilievo minore ai fini della nostra indagine. Tuttavia nessuno nega che abitare in un piccolo paesino o in una grande città comporta significative differenze per ciò che concerne gli aspetti relazionali. In ragione di ciò, ci è sembrato utile raccogliere questo tipo di informazioni.